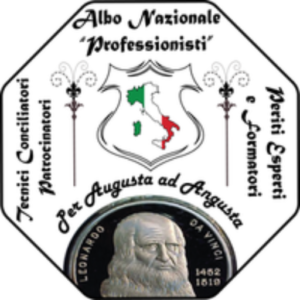Riforma Cartabia: le notifiche via PEC
GU-L-n.-87_2023-conversione-DL-n.-51_2023
Le innovazioni introdotte dalla cd. ‘Riforma Cartabia’ a mezzo del D.Lgs. 149/2022 non hanno solamente riguardato l’ambito strettamente processuale del diritto civile, ma si sono altresì amplificate in tutte quelle attività che, come le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, sono abitualmente compiute dai difensori nell’esercizio delle proprie prerogative professionali.
È stato infatti fatto obbligo di procedere alla notifica via PEC ogniqualvolta il destinatario sia tenuto per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, ovvero abbia eletto un proprio domicilio digitale ai sensi del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale, contenuto nel D.Lgs. 82/2005).
Quali sono i Pubblici Elenchi?
L’art. 3-bis della Legge 53/1994 prevede che la notifica con modalità telematiche possa essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, e ciò tanto per quanto riguarda il mittente, che i destinatari di tale notifica.
Tali pubblici elenchi sono quelli indicati dall’art. 16-ter della Legge 221/2012, ovvero quella di conversione del cd. ‘Decreto Crescita 2.0’.
Non tutti i registri autorizzati sono però totalmente sovrapponibili, ma occorre invece prestare la dovuta attenzione a quale consultare, soprattutto con riferimento alla natura del soggetto destinatario della notifica.
Quali differenze tra ReGIndE ed INI-PEC?
Nella pratica, gli elenchi PEC più comunemente utilizzati sono il ReGIndE e l’INI-PEC.
Il primo è il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito direttamente dal Ministero della Giustizia, ove sono contenuti i dati dei soli cd. ‘soggetti abilitati esterni’, ovverosia tutti coloro a cui, in virtù del proprio titolo o qualifica di rango non ministeriale, è consentito interagire con un ufficio giudiziario nell’ambito del processo civile telematico (ad es. avvocati, curatori e consulenti tecnici).
Il secondo è invece l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico e riconosciuto dal predetto Codice dell’Amministrazione Digitale per consolidare i riferimenti di tutti i soggetti all’obbligo legale di domicilio digitale, a loro volta suddivisi fra Imprese e Professionisti.
Quest’ultimo, peraltro liberamente accessibile senz’alcuna autenticazione, si rivela quindi preferibile per ricercare correttamente la casella PEC dei privati iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o in tutti gli albi professionali, dagli agenti di cambio ai veterinari.
I soggetti pubblici: Registro PP.AA. ed I.P.A.
Quanto agli indirizzi facenti capo ad enti pubblici, l’elenco d’elezione è costituito dal Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, sancito ai sensi dell’art. 16, co. 12 del D.L. 179/2012 ed anch’esso gestito dal Ministero della Giustizia nell’ambito del Portale dei Servizi Telematici.
La consultazione di tale banca dati è riservata ai soli detentori dei certificati muniti di apposito token crittografico per l’accesso ai servizi giudiziari, quali avvocati ed ufficiali giudiziari.
Essendo il Registro PP.AA. ancora in fase di completamento, in via residuale l’art. 28 del D.L. 76/2020 permette l’utilizzo degli indirizzi presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) ogniqualvolta il corrispondente campo nel PP.AA. non sia già stato popolato. In questo caso, il mittente dovrà però aver cura di corredare la relata di notifica dalla specifica che l’indirizzo PEC del destinatario sia stato estratto da I.P.A. perché non presente nel Registro PP.AA.
I domicili digitali volontari: l’INAD
Pur anch’esso previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, solo di recente l’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese è stato formalmente pubblicato, e ad oggi è già in grado di ricevere gli indirizzi PEC che qualsiasi cittadino può indicare come proprio domicilio digitale, dove poter altresì ricevere tutte le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione.
Benché l’adesione a tale registro sia su base del tutto volontaria, in ragione della Riforma Cartabia essa comporta la necessità di prediligere l’indirizzo PEC censito nel registro INAD per destinarvi qualsivoglia notifica giudiziale, la quale, pertanto, dovrà effettuarsi con modalità telematiche.
Quale banca dati è la migliore
In considerazione di quanto sopra accennato, la risposta a questa domanda rimane, come nella migliore tradizione legale… dipende! Non esiste una banca dati onnicomprensiva di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata cui validamente inviare una notifica telematica, ma occorre invece selezionare quella (o quelle) in cui ricercare lo specifico soggetto destinatario, a seconda della sua appartenenza alle diverse categorie in cui sono tutt’ora suddivisi i suddetti pubblici elenchi.
Occorre infatti tenere bene a mente che la notifica PEC effettuata verso un indirizzo ‘erroneo’, perché non appartenente alla banca dati preferenziale per quel determinato destinatario, può comportare un vizio insanabile, tale da impedire il perfezionamento della notifica stessa.